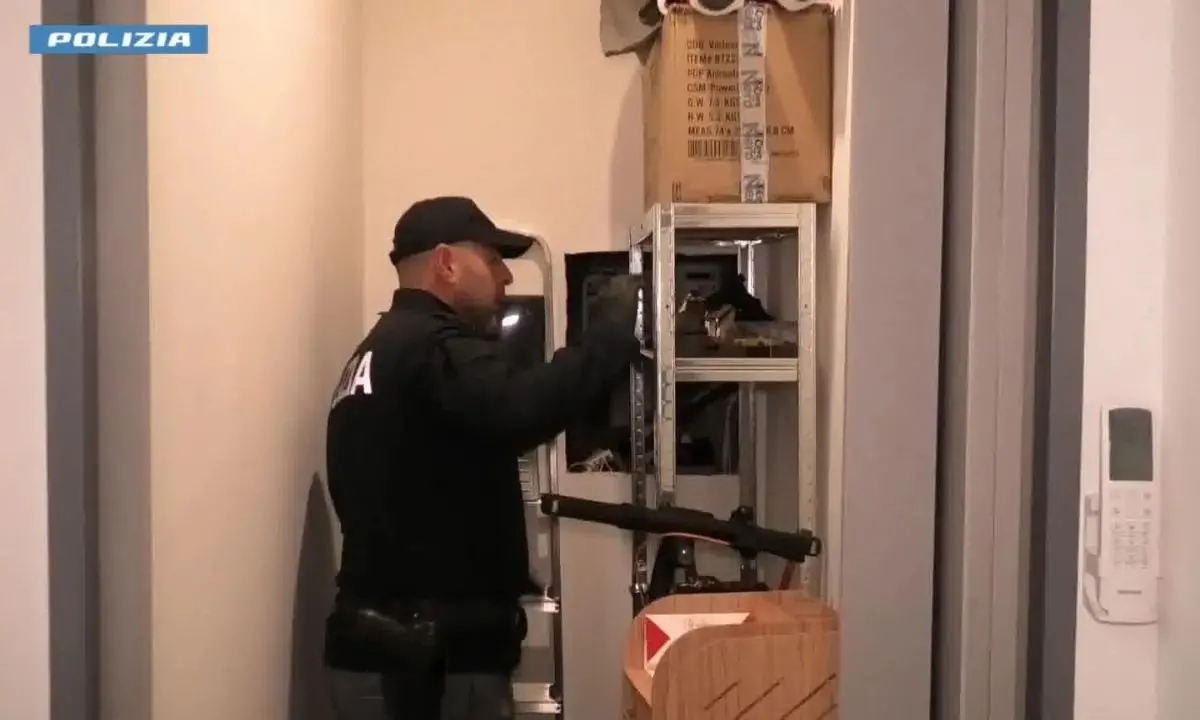Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni

Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni

Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni

Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni

Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni

Sergio Cosmai, l'omicidio più "eccellente" di Cosenza compie 40 anni
Chi era Sergio Cosmai? E perché fu ucciso? Quarant’anni dopo, ripercorriamo la triste vicenda che lo riguarda attraverso la cronaca di quei giorni, le sentenze e i profili dei suoi carnefici, protagonisti oscuri del delitto più “eccellente” avvenuto nella città di Cosenza.
L’omicidio – Due sicari con la parrucca
Il 12 marzo del 1985, il trentaseienne Sergio Cosmai percorre alla guida della sua Fiat 500 una strada di periferia che collega la città di Cosenza con la vicina Rende. È un vialone lungo e diritto, in una zona oggi ad alta densità abitativa ma che allora è di aperta campagna, sporcata qui e là dal cemento di qualche palazzo. Ignora che, un giorno, proprio quella strada porterà il suo nome. Sta andando a prendere la sua figlioletta all’asilo per riportarla a casa. Lo fa ogni giorno, dopo aver staccato dal lavoro. Da circa due anni e mezzo è alla guida della casa circondariale di Cosenza, ma in quel periodo gli tocca dirigere anche il carcere di Vibo Valentia, città nella quale si reca per tre volte a settimana. Cascasse il mondo, però, non si sottrae mai a quell’incombenza familiare. Lo sanno tutti, anche i suoi assassini che da settimane lo pedinano, studiandone le abitudini. E quel giorno decidono di entrare in azione.
All’improvviso una Colt verde taglia la strada alla 500 di Cosmai. A bordo c’è una coppia di sicari del clan Perna-Pranno, Dario Notargiacomo e Stefano Bartolomeo. Indossano barbe posticce e parrucche acquistate a Roma, in un negozio di Porta Maggiore che vende articoli per il teatro. Scendono dall’abitacolo e cominciano a fare fuoco con una pistola e un fucile a canne mozze. Il direttore è ferito, ma ha il tempo di reagire: innesta la retromarcia e tenta di la fuga, ma il killer continua a sparare senza tregua. E non appena la 500 arresta la marcia, il commando si dà alla fuga. Nicola Notargiacomo, il fratello di Dario, li recupererà qualche km più avanti a bordo di un’auto pulita. Cosmai non è ancora morto, ma all’arrivo dei soccorritori le sue condizioni sono più che critiche. Per salvargli la vita, si tenta il trasferimento disperato in una clinica pugliese, lì dove purtroppo il suo cuore cesserà di battere.

Gli investigatori dell’epoca non hanno neppure il tempo di ragionare sul possibile movente che, già poche ore dopo, un testimone offre loro su un piatto d’argento i responsabili dell’omicidio. I Notargiacomo e Bartolomeo, dunque finiscono in carcere, mentre il fratello di quest’ultimo, Giuseppe Bartolomeo, parimenti coinvolto con il ruolo di “staffetta”, riesce a evitare l’arresto. All’epoca, il Codice prevede che il processo non si celebri nel Tribunale più vicino al luogo in cui è stato commesso il crimine, ma in quello dove è deceduta la vittima. E così, nel 1987 il dibattimento si farà nella città di Trani. (clicca avanti per continuare)
I processi – Gli assassini la fanno franca
Il processo è squisitamente indiziario e arriva in un’epoca in cui non esistono leggi sui collaboratori di giustizia. Al primo round, la Corte d’assise di Trani si pronuncia a favore dell’ergastolo, in virtù di una serie di indizi che sembrano combaciare alla perfezione. Dopo aver ucciso Cosmai, infatti, Stefano e Dario abbandonano la Colt verde in un cortile di Commenda. Qui, però, sono avvistati da alcuni inquilini del palazzo, tra cui un ragazzino di dodici anni. Quest’ultimo, nota anche l’arrivo del terzo complice (Nicola) a bordo di una Fiat 127 bianca e im seguito riferirà tutto alla polizia, indicando la foto di Stefano Bartolomeo come uno dei due uomini scesi dalla Colt.
Lo riconosce in mezzo alle segnaletiche di altri 194 pregiudicati. «È lui» dice senza alcuna esitazione e a quell’indicazione segue un riflesso condizionato: gli agenti si fiondano immediatamente fuori dalla stanza per andare ad arrestare il loro primo sospettato. Grave errore, se ne accorgeranno in seguito. Le successive indagini consentono di accertare che, quel 12 marzo, Bartolomeo ha incontrato i suoi amici Dario e Nicola. E che quest’ultimo possiede una Fiat uguale a quella descritta dal giovane testimone. Nessuno dei tre, inoltre, presenta un alibi in grado di posizionarli lontani dalla scena del crimine nel pomeriggio incriminato, e questi indizi messi a sistema convince la Corte d’assise di Trani a punirli con il carcere a vita. Per prendere quella decisione, i giudici impiegano solo cinquanta minuti.

In Appello, però, le prove sono riviste sotto una luce diversa. La testimonianza del bambino? Insufficiente, proprio in virtù della sua tenera età. Da evidenziare poi, che al primo riconoscimento fotografico (che per la foga e l’emozione del momento non viene neanche verbalizzato) ne segue un altro in cui le certezze cominciano a non essere più tali. Stefano Bartolomeo, infatti, non è più l’uomo della Colt, bensì uno che «gli somiglia». Addirittura, durante il dibattimento, il ragazzino fa dietrofront. Lo fa per paura, forse è stato anche minacciato, ma arriva a dire di essersi inventato tutto per «eccesso di protagonismo». Dettagli sui quali i giudici di Trani sorvolano, ma che per quelli di Bari diventano determinanti.
Sintomatico poi il coinvolgimento dei due Notargiacomo. Nessuno li vede personalmente, ma sono amici di Bartolomeo che, invece, è stato “riconosciuto” dal testimone. Per loro stessa ammissione, inoltre, i tre si sono incontrati il 12 marzo 1985, giorno dell’omicidio, e, in più, Nicola ha la 127 bianca che tutti cercano. E non solo. Se non fosse la cronaca di una tragedia, l’ultima prova raccolta all’epoca contro i due fratelli, farebbe un po’ sorridere: il ritrovamento nella loro abitazione di alcune riviste specializzate in tema di armi. Il risultato è tutti assolti «per insufficienza di prove». (clicca avanti per continuare)
Il movente – Un uomo onesto, un uomo probo
Quando muore Cosmai, sua moglie Tiziana Palazzo è all’ottavo mese di gravidanza. Poco più tardi darà alla luce il piccolo Sergio, chiamato così in onore di un padre che non fa in tempo a conoscere, ucciso trenta giorni prima della sua venuta al mondo. Ma chi era Sergio Cosmai? Originario di Bisceglie, in Puglia, arriva a Cosenza il 30 agosto del 1982 da giovane funzionario dello Stato con diverse esperienze già maturate sul campo. Gli esordi lo vedono vicedirettore delle carceri di Trani e Lecce, poi in Calabria a dirigere prima Locri e poi Crotone. Due posti caldi dove, però, Cosmai non avrà mai problemi. Anzi, quando abbandona il Reggino, arriva anche a piangere. «Perché lì aveva costruito rapporti veri» ricorderà in seguito la sua vedova durante un processo.
Le rogne si manifestano con il suo arrivo nella città dei Bruzi. Il “benvenuto” glielo danno a venti giorni dall’insediamento, con una sparatoria tra detenuti divenuta celebre per la presenza del futuro latitante Edgardo Greco. Quella volta, Tiziana Palazzo assiste alla scena perché il suo alloggio affaccia proprio sul muro di cinta della prigione. All’epoca, nella casa circondariale entrano armi e i detenuti non tengono in alcun conto l’autorità delle guardie penitenziarie che, a volte, sono prese finanche a schiaffi.

Nulla di strano dato che, in precedenza, nel vecchio carcere di Colle Triglio accadeva persino di peggio. I boss e i loro affiliati comunicavano con l’esterno tramite le finestre e da lì qualcuno si spingeva anche a ordinare delitti se non, addirittura a restarne vittima, come nel caso degli sfortunati Mario Lanzino e Carlo Mazzei. Insomma, una situazione che in quei giorni suggerisce a funzionari di mezz’Italia di rifiutare la destinazione cosentina poiché ritenuta «impossibile da gestire».
Tuttavia, dopo due anni e mezzo di permanenza in città, Cosmai è sereno. A ricordarlo, è sempre la Palazzo: «Aveva chiesto il trasferimento a Taranto. Diceva che ormai a Cosenza la situazione era sotto controllo e che il carcere andava avanti da solo». L’ordine lo ha ristabilito applicando regole severe, disapprovate però dal magistrato di sorveglianza, il giudice Saltalamacchia, con cui gli scontri sono frequenti. L’episodio famigerato della rivolta in carcere, nell’agosto ’83, gli vale un’inchiesta da parte della Procura, ma nessuno immagina che sarà anche il movente del suo omicidio. Quel giorno, i detenuti si rifiutano di rientrare in cella, chiedendo un’ora d’aria in più rispetto al consentito. Gli uomini di Cosmai ci vanno giù duro con i manganelli e qualcuno mette in circolo la voce che alla spedizione antisommossa abbia preso parte anche lui, il direttore. Secondo i pentiti, è allora che matura il proposito di vendetta da parte dei killer. (clicca avanti per continuare)
Dario Notargiacomo – La banalità del male
«Niente di personale contro di lui. Anche perché di botte in carcere, io non ne ho mai preso». Dario Notargiacomo riassumerà così la sua partecipazione all’omicidio Cosmai: con una formula banale. Proprio come il male. Lui e suo fratello Nicola possono definirsi a tutti gli effetti, dei sopravvissuti. C’è stato un momento, infatti, in cui tutti sembravano interessati a fare loro la pelle: Cosentini, Corleonesi, perfino la Banda della Magliana. Eppure trenta e passa anni dopo Dario è ancora qui. «Non andare mai agli appuntamenti», è anche questo il segreto della sua longevità.
Dal 1994 i due fratelli collaborano con la giustizia, una scelta che ha fatto evitare loro la sorte occorsa invece ai Bartolomeo, inghiottiti dalla lupara bianca tre anni prima. E così, nelle rinnovate vesti di pentiti di ‘ndrangheta, i Notargiacomo hanno ammesso che sì, a uccidere il direttore del carcere erano stati proprio loro insieme agli amici Stefano e Giuseppe. La legge proibisce di processare due volte una persona per lo stesso reato, quindi tocca prenderne atto: l’hanno fatta franca.

A partire dal 2006, però, le loro confessioni consentono di portare alla sbarra il mandante di quel delitto, il boss Franco Perna, l’uomo al quale più di ogni altro non andava giù il rigore legalitario che Cosmai aveva imposto all’interno del carcere. «Voleva partecipare lui stesso all’azione, ma poi ebbe problemi con la giustizia e così ci mandò a dire: “Dove c’è gusto non c’è perdenza”. Un modo per comunicarci che l’operazione doveva andare avanti lo stesso» dichiarerà Dario Notargiacomo durante il processo culminato poi nella condanna di Perna all’ergastolo. Un verdetto che a differenza di quelli precedenti non è più mutato.
Da ragazzo faceva il ballerino di danza classica, lui e suo fratello Nicola erano studenti – anche brillanti – del liceo classico Telesio. Cresciuti in una famiglia normale, priva di retaggi criminali, cosa li ha portati a trasformarsi in mafiosi? «Il fascino dell’uomo dell’ambiente, all’epoca era una moda» suggerirà suo fratello Nicola. Più intimista, invece, la versione data da Dario all’atto del suo pentimento: «Dicono spesso che ho buttato via la mia intelligenza. Il fatto è che nella mia vita gli scrupoli hanno sempre pesato sulle scelte criminali. Forse è per questo che mi sono perso». Parole che suonano bene anche come personale epitaffio. (clicca avanti per continuare)
Epilogo – Non lo uccise il «dovere», ma la mafia
Sono passati quarant’anni dalla morte di Sergio Cosmai. Tanto tempo, che dovrebbe fare della vicenda un caso ormai storicizzato. Eppure non è così. Non solo perché alla condanna del mandante dell’omicidio si è giunti solo in epoca più recente. Tra le ferite aperte, infatti, spicca l’offesa arrecata alla sua famiglia da parte di uno Stato che, per anni, ha considerato il direttore del carcere di Cosenza solo alla stregua di «vittima del dovere» piuttosto che della mafia. E a ciò si aggiunge il processo pugliese conclusosi in gloria per gli esecutori materiali del delitto.
In quel caso i giudici sbagliarono in buona fede oppure no? No, secondo Mario Pranno che, ai tempi della sua collaborazione meteorica, insinua che il suo clan avesse versato ottanta milioni di lire per aggiustare quel processo. A chi? L’ex boss di San Vito non lo ha mai precisato. Oltre a lui, un altro collaboratore di giustizia, Franco Garofalo, paventa una situazione analoga, ma sempre in modo vago. E invece di fugare i dubbi, finisce per alimentarli. Anche perché, una volta usciti dal carcere, Bartolomeo e i Notargiacomo danno il via a una sanguinosa faida interna al loro gruppo proprio perché lamentano di non aver ricevuto assistenza dalla “casa madre” durante la detenzione.
L’unica certezza, ma col senno di poi, è che si trattò di un errore giudiziario. Va da sé che se il verdetto finale fosse stato di condanna, Stefano Bartolomeo sarebbe in carcere ma ancora vivo e non inghiottito, chissà dove, dal gorgo della lupara bianca. A Cosenza non ci sarebbe stata una seconda guerra di mafia e i Notargiacomo non avrebbero mai collaborato con la giustizia. Forse non si sarebbe mai aperta la stagione dei maxiprocessi, chissà.
Il tutto a ulteriore conferma di come certe tragedie siano in grado di determinare più di altre il corso degli eventi. E più in generale la Storia. Ucronie a parte, però, solo una cosa sarebbe rimasta immutata: niente e nessuno avrebbe potuto riportare in vita Sergio Cosmai. Uomo dello Stato e funzionario integerrimo. Vittima della ’ndrangheta.

Tutti gli articoli di Cronaca